1987

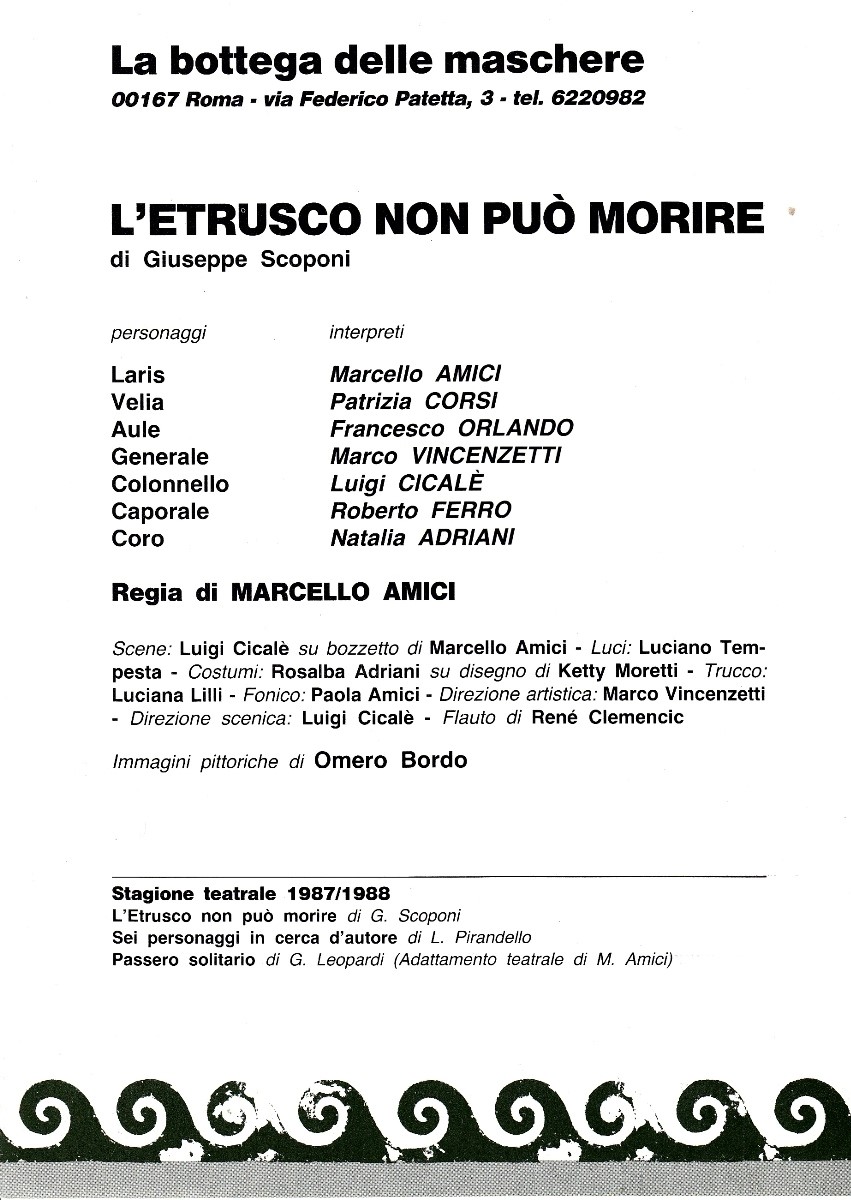

NOTE DELL’AUTORE
Sono nato a Roma, ma sulla mia formazione ha sempre pesato in modo determinante il paese di origine di mia madre, Tarquinia. Mi sono perciò formato su due culture, tra due patrie.
II tempo, però, la naturale maturità, certi ricordi dell’infanzia, i lunghi mesi passati ogni anno tra la gente e i lavori della campagna, ricca di tradizioni che, ancora negli anni immediatamente precedenti la guerra, poco si discostavano dai secolari archetipi, hanno pian piano preso il sopravvento.
E poi gli incontri con la storia, non solo etrusca, la continua sopraffazione esercitata dai popoli più forti, amanti delle armi, assetati di conquista, che dagli antri più oscuri della coscienza, uscivano alla luce come tremende armate di formiche da nascosti nidi di violenza per sopraffare altri popoli meno dediti alle armi, ma sicuramente più ricchi di cultura e di commerci, mi hanno sempre colpito, spingendomi a cercare un comune denominatore a cicli che si sono ripetuti nei secoli, nei millenni.
E sempre, dietro le accuse di pretesi torti subiti, di immonde tare ascritte ad alcune razze, di pratiche contro la morale dei popoli, dietro a conclamate spinte verso spazi vitali, c’è stato sempre il desiderio rapace di impadronirsi di ricchezze, di posizioni chiave di commerci terrestri o marittimi.
Questi popoli nel tempo si sono chiamati Persiani, Macedoni, Romani, Unni, Nazisti… Eserciti bene armati e bene addestrati che, all’inizio, hanno sempre avuto la meglio sui popoli amanti della pace e quindi impreparati ma che poi il tempo, con la sua falce imparziale, ha ridimensionato riconducendoli nell’alveo di un flusso livellatore.
Ecco perché ho scelto la storia dell’ultimo, tragico scontro fra Tarquinia e Roma.
Gli accenti dei personaggi sono veri, sofferti. II mito degli Etruschi vive in modo moderno, come fossero uomini del nostro tempo a parlare, con i problemi di oggi, che sono poi gli eterni problemi dell’umanità.
Parlano e soffrono come hanno parlato e sofferto nei secoli quei popoli che hanno dovuto cercare la sopravvivenza nella fuga, nella diaspora o nella mimetizzazione con il vincitore, nei tanti luoghi del tempo e dello spazio.
Giuseppe Scoponi
NOTE DI REGIA
La «Tomba dell’Orco», la tomba della morte, è la scena de «L’etrusco non può morire»; ma non è tragedia, perché il cielo non è ostile ma indifferente, perché manca il coro nell’agorà che si interroga sul caso che suscita pietà e terrore, non ci sono colpevoli e il destino non rende precario il possesso della felicità. Solo nei silenzi che di tanto in tanto si aprono nell’ipogeo, sembra di sentire le note di un flauto. La storia coglie il momento della fine del potere etrusco e l’inizio del successivo inglobamento di quel popolo nella cultura e nel pensiero romano. Livio fissa questo periodo a cavallo degli anni tra il 394 e il 390 a.C.
Quando il sipario si apre, il coro, come una Lasa, si muove tra gli spaventosi Charu e Tuchulcha e la tristezza che modella i volti dei defunti. Le penne delle ali di Charu sono rigide come una uniforme e acute come quelle degli uccelli rapaci, mentre quelle di Tuchulcha somigliano alle ali di un pipistrello come un grigio mantello; serpenti si drizzano, si annodano sulla testa, si ergono dinanzi agli odiosi profili dei due demoni. E un composto d’animalità e un concentrato di malvagità. Sono lì fissi nel tempo. Gli anni hanno messo loro divise naziste: nel mondo c’è l’ombra del male, nella società i germi della corruzione, ogni bene ha la sua condanna di morte. Qui i personaggi vestono le uniformi dell’esercito nazista perché rappresentano la macchina bellica di uno stato che nella guerra di espansione riconosce la sua sola ragione di esistere. Rappresentano il segno della sopraffazione che i popoli più deboli, o solo più amanti della pace, hanno conosciuto da parte degli invasori, che si chiamassero Persiani, Unni o Romani.
«… La forza emergente di Roma, con la sua potenza e il suo cinismo, piega la nazione etrusca quando si incontra con essa al bivio della storia. Una furia cieca che nel tempo indossa armature e divise dai disparati colori, un fiume di violenza che avvolge nelle sue spire il mondo…».
Già sconfitti dai Romani, gli Etruschi segnano una tregua durante la quale si adagiano nelle comodità, in una inerzia politica. Laris, Lucumone di Tarquinia, avverte questa apatia spirituale; il nemico romano è più forte, più potente, preparato alla guerra e «con il miraggio delle belle cose che noi possediamo e delle quali siamo talmente sazi che ci è venuta meno anche la voglia e la forza di difenderle». Triste è la bellissima Velia, il profilo dritto è teso come un arco da cui scocca uno sguardo carico di malinconia; è Antigone che si ribella a Creonte, è Ecuba che s’aggira tra le rovine fumanti di Troia, è Medea che parla al coro muto della storia della nazione etrusca. Velia assapora la delusione amara della vita e il disinganno della morte, le sue parole sono la storia del popolo etrusco; sul finale racchiudono un sospiro capace d’empire di doloroso affanno tutta la Tomba dell’Orco. II riverbero dei fuochi in cui bruciano i libri e i templi di Tarquinia si fa sempre più forte, la sua luce fuga completamente le ombre della tomba e dalle strade arrivano grida in una lingua nemica, uncinata. Gli invasori pensano di distruggere cosi il mito di una Nazione e consegnare alle future generazioni del popolo etrusco un’immagine labile della sua storia.
— … neanche la nostra storia e la nostra cultura bruciano in quelle fiamme. Tutte le citta dell’Etruria hanno nascosto, affidandoli al grembo di questa nostra terra, libri, testimonianze della nostra grandezza e il segreto della nostra potenza. Veio il suo Apollo, Arezzo la Chimera, Chiusi, Volterra, Felsinia, ognuno i simboli più sacri. Tarquinia ha spiccato dal frontone del tempio i cavalli alati e il cocchio del sole. Quando la luce dell’astro li ritroverà di nuovo aggiogati nel primo saluto del mattino, allora anche la potenza dell’Etruria tornerà a risplendere… —


